LO SCRIPTORUM
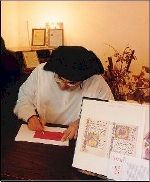
Tutti
sappiamo, oramai, che furono i monaci medioevali i maggiori amanuensi
della storia. Lo scriptorum era
un’officina scrittoria fornita, come nelle aule scolastiche, di regolari
sgabelli. Assorti nel loro lavoro, i
certosini, e il caso di dire, sbuffavano quando, probabilmente,
secondo il rituale, un collega si affacciava sull’uscio per rammentare
il memento mori. Dal momento che
non era stato ancora inventato il vetro, si dice che i poveretti
incontrassero molte difficoltà durante il lavoro. Sebbene adoperassero
oggetti adeguati per fermare le scartoffie, non vi erano, purtroppo, le
aspirine per combattere i frequenti raffreddori. I cenobiti, in genere,
non erano avvezzi a tabacco e a
Venere, ma in quanto a Bacco...
Altro che prevenzione dei malanni! Poi, grazie all’avvento della carta
oleata, gli amanuensi trovarono maggiore difesa contro le scalmane. Si
dice che i monaci, tra l’altro buone forchette, divorassero
bulimicamente, date le diverse astinenze, pecore e selvaggina, scuoiate
allo scopo di ricavare la materia prima per fabbricare il supporto
destinato alla scrittura. Alcuni religiosi fungevano pure da miniaturisti
per disegnare quelle complesse maiuscole e per illustrare qua e là i
codex. Vi erano dei testi così estesi e complicati che spesso non bastava
1’intera vita di un amanuense per realizzarne una copia. Prima ancora
che sorgesse la copiatura laica quasi tutti i testi, non teosofici,
venivano burattati da dissolutezze ed impudicizie. Per fortuna il Decamerone non cadde mai nelle grinfie dei monaci...
E’ superfluo aggiungere che la copiatura avveniva sia attraverso il
lavoro individuale che dietro dettatura del bibliotecario. E quante volte,
c’è da immaginarselo, un po’ per il tedio, un po’ per il sonno,
l’uno avrà dettato patate e
1’altro avrà scritto cipolle.
In ogni modo i monaci avevano libero arbitrio di purgare, modificare,
intrapolare o estrapolare. Gia ai tempi dei romani, però, esistevano
officine scrittorie frequentate da schiavi. Dall’anno uno
ab urbe condita, al 1450 dell’Era Cristiana gli amanuensi hanno
rappresentato il lungo periodo di preludio della storia della stampa,
perché, appunto, sono stati i precursori pazienti e un po’ secchioni,
delle arti grafiche. Fu probabilmente il loro superlavoro a suggerire
1’invenzione a Gutenberg. Gia dal VII secolo, intanto, esistevano delle
sparute officine laiche che si moltiplicarono, nel tempo, molto
lentamente.
NON
DI SOLO AMANUENSE
Non bisogna dimenticare, però, che uno dei primi
sistemi di stampa fu inventato dai cinesi. Gli orientali adoperarono
dapprima caratteri di terracotta per stampare i loro singolari giornali.
Nel VII secolo apparvero i primi caratteri di rame e altre leghe. Il
metodo si rivelò problematico se si considera che l’alfabeto cinese
comprende circa cinquemila segni. Così, mai scoraggiati, inventarono la
stampa tabellure, altrimenti detta
xilografia. Essa consiste (perché per finalità artistiche ancora si
pratica) nell’utilizzare come matrice una tavoletta per lo più di legno
incisa a mano. Il risultato era pressappoco simile a quello dei clichè
zincografici, ottenuti con 1’ausilio di un negativo fotografico, la luce
attinica e la morsura d’acido, adoperati tutt’oggi dalle tipografie
tradizionali.
Idonea per la riproduzione di immagini, la xilografia non risolveva il
problema della composizione alfabetica. Diffusasi pure in Europa non cadde
in disuso, infatti dopo l’invenzione della stampa a caratteri mobili
venne utilizzata come ausilio alla nuova scoperta per illustrare le opere
stampate, data la sua ottima compatibilità col torchio. E’ pur vero che
sulla tavoletta era possibile incidere quante lettere dell’alfabeto si
volesse, ma a parte la laboriosità del sistema, la matrice, essendo
monoblocco, non consentiva correzioni; inoltre lo strofinio vigoroso degli
xilografi nella parte posteriore del foglio non concedeva la possibilità
di stampare ripetutamente sul fronte retro. I caratteri mobili risolsero
ogni problema. Sebbene alcune polemiche sulla paternità assoluta di
Gutenberg della stampa tipografica non si siano mai del tutto dissipate,
la storia vuole che 1’orefice di Magonza, nel 1450, iniziasse a
sperimentare gli strani bastoncini di piombo fuso, aventi sull’estremità
superiore il rilievo delle lettere a rovescio. Come è facile capire, lo
scopo che si era prefisso quell’astuto di tedesco fu quello di rendere
rapida non già la formazione delle pagine, ma la copiatura di esse una
volta ultimate. Johan Gutenberg, come ho detto, era orefice di professione
e, guarda caso, Torre del Greco, la mia città, ovunque riconosciuta come
Patria del Corallo, trabocca di orafi ed orefici. Ma sono certo che nessun
torrese trascurerebbe l’oro per mettersi a fondere il piombo. Gutenberg
lo fece, ma posso assicurarvi che non era uno stupido. Cercava sì
la gloria ma, come gli alchimisti, riteneva la sua invenzione una
vera pietra filosofale, perché, appunto, tentava di trasformare il piombo
in oro, coi ricavi del suo notabile operato, in origine, comunque, non
poco contrastato, come tutte le grandi innovazioni della storia.