CLICHE’ DI
ZINCO
ADDIO!
(Descrizione degli anni 80 N.d.r.).
Il sogno, invece, dei tipografi artigiani comuni, è
stato sempre quello di poter realizzare cliché nella stessa bottega. Le
complesse fasi del procedimento zincografico hanno sempre scoraggiato
anche i tipografi più intraprendenti. Gli zincografi, agli occhi dei
tipografi del piombo fuso, sono sempre apparsi come una sorta di
alchimisti privilegiati che indettavano maestrie tecnicistiche e che,
comunque, esercitavano un certo ascendente sui loro asserviti. Ma la
chimica industriale ha fatto giustizia, ha messo a punto i composti
fotopolimerici, i quali consentono di ottenere cliché in casa attraverso
un procedimento (come cadono bene le locuzioni):
all’acqua e sapone e
all’acqua di rose. Infatti, dopo la semplice fase di esposizione, lo
sviluppo avviene in acqua di rubinetto.
Bisogna ricordare che, per quanto la stampa offset abbia soppiantato
quella a caratteri mobili vi sono delle lavorazioni che restano
tipografiche e, allo stato, non si possono sostituire: stampa in oro tramite foil, stampa di supporti cartacei preconfezionati,
rilievografia classica e chimica, ecc.
Vediamo, per il momento, come viene fabbricato un cliché di zinco al
tratto. Devo subito puntualizzare che il procedimento fotografico per
ottenere la matrice di qualsivoglia veicolo di stampa e sempre lo stesso.
E’ necessaria, in tutti i casi, una maschera che consente alla luce
attinica di agire o meno. Questa matrice della matrice, per così dire, è
essenzialmente costituita da una pellicola o un montaggio di pellicole
fotografiche. Per ottenere un semplice cliché di zinco, dobbiamo
sfruttare la contrapposizione della pellicola ortocromatica ad alto
contrasto: nero totale o bianco assoluto. Immaginiamo di voler convertire
in cliché anastatico un disegno o una pagina di scritto. Fotograferemo
l’originale con un apparecchio specifico capace di incamerare negativi
di grosso formato o più semplicemente scannerizziamo la pagina fino ad
ottenere con il procedimento disponibile: laser, fotounità, ecc. una
pellicola negativa che risulterà, come è noto, nera la dove le zone
dell’originale sono bianche, e trasparente dove sull’originale risulta
nero.
Lo zincografo avrà preventivamente preparato la lastra di zinco con una
speciale vernice fotosensibile, spalmata in centrifuga onde ottenere uno
strato omogeneo. Fatta essiccare, la lastra viene sottoposta alla
pellicola a perfetto contatto in appositi bromografi sotto vuoto. La luce attinica agirà solo attraverso le
zone trasparenti, nel nostro caso i segni delle lettere e il disegno. La
vernice fotosensibile indurirà solo nei punti colpiti dalla luce. Le zone
neutre rimarranno solubili allo sviluppo che lascerà, in quei posti,
ricomparire il metallo. E fin qui nulla di complicato, a parte la
centrifugazione del bicromato sensibile sullo zinco. La difficoltà si
presenta quando si immerge la lastra in acido nitrico che corroderà lo
zinco solo nei punti esenti di vernice. La laboriosa incisione è sotto
costante controllo dell’operatore che eviterà innanzitutto attacchi
impropri dell’acido al fianco dei rilievi delle lettere in formazione.
Quando 1’incisione chimica avrà raggiunto la profondità desiderata il
cliché è bello e pronto per la stampa. Esso avrà l’aspetto del
bassorilievo di un comune timbro, laddove gli elementi grafici sono
disposti a rovescio e in rilievo e le parti bianche (sulla carta)
sottoposte. Il procedimento fotopolimerico è pressoché identico con la
differenza che non esiste acidazione, lo “scavo” del bassorilievo
avviene spazzolando con acqua di rubinetto tiepida. Ciò consente a
chiunque di fabbricare cliché di “plastica”.
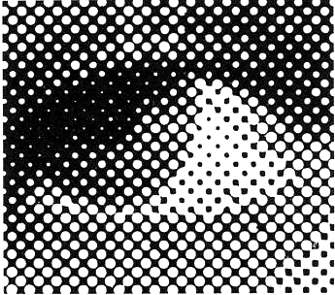
Fin qui abbiamo appreso che i segni in superficie del
cliché raccolgono il colore dai rulli inchiostratori delle macchine
tipografiche per trasferirlo sulla carta, similmente alla funzione del
rilievo dei caratteri mobili. Le zone più basse che costituiscono la base
dei rilievi di stampa non sfiorano i rulli e risultano bianche sulla
carta. Ma come si ottengono le tonalità di grigio in una foto stampata?
Se proviamo a tracciare su d’un comune foglio bianco tanti puntini
precisi ed equidistanti tra loro noteremo che alla distanza di qualche
metro essi scompariranno dal nostro controllo visivo ed apparirà una zona
di una distinta tonalità di grigio. Più piccoli e distanti saranno i
puntini, minore sarà l’intensità del grigio. Per ottenere un grigio
piuttosto scuro dobbiamo tracciare dei punti più nutriti e più
accostati. I punti addossati o fusi formano il nero. Se queste tracce
vengono articolate in relazione a delle figure otterremo una rudimentale
immagine tipografica da giornale.
Il clichè riproducente una fotografia ha lo stesso principio del nostro
puerile esperimento, è composto da parti microscopiche totalmente nere o
bianche, quindi alte e basse. Il segreto sta nella caratteristica
microbica dei mirmifici puntini, che non vengono percepiti ad occhio nudo
come tali, ma quali zone grigie più o meno scure che vanno appunto dal
bianco al nero. Un cliché di una foto, detto a mezzatinta, presenta, nella sua struttura, una miriade di punti
di microbica dimensione a diversa distanza da loro: piccolissimi e
distanti nelle zone chiare; più sostenuti e ravvicinati in quelle medie;
quasi uniti nelle parti scure, nelle zone nere sono fusi assieme e si va
nel fondino tipografico. Quindi
l’omogeneità dell’inchiostro distribuito dai rulli viene rotta dalle
differenti zone di presa dei puntini.
A scomporre l’immagine in punti, in sede fotomeccanica, è il
retino, costituito da un supporto dello spessore vario, a seconda se
si tratta di retino a distanza o a contatto. Il retino a contatto, molto
diffuso e pratico, è spesso quanto una pellicola e altrettanto
flessibile, nella cui base semitrasparente appaiono fittissime serie di
linee orizzontali e verticali, l’incrocio delle quali forma i punti che
allo stato di retino sono tutti uguali. Essi si assottigliano per
riflessione ottica della luce in fase di ripresa lungo le parti chiare
dell’immagine; al contrario nelle parti scure si ingrossano perché la
luce riflessa è minore. Il retino viene anteposto, a stretto contatto
(sottovuoto), alla pellicola vergine in fase di ripresa o nei passaggi da
negativo in positivo e viceversa. I retini vanno da un minimo di 25 linee
a cm. quando il cliché è destinato ad una carta ruvida come quella dei
giornali; 40 linee per carte collate e lisciate, fino ad 80 linee ed oltre
per le carte patinate. L’offset consente un maggior numero di linee del
retino, perché il sistema trasferisce solo un sottile velo di inchiostro
ed evita l’impasto dei punti. Il retino 25 linee dei giornali è
visibile ad occhio nudo come la luna ed il sole. Per osservare bene una
retinatura oltre le 60 linee è necessaria una buona lente
d’ingrandimento. Oggi la selezione dei colori è totalmente
computerizzata e la possibilità di errori è minima.