|
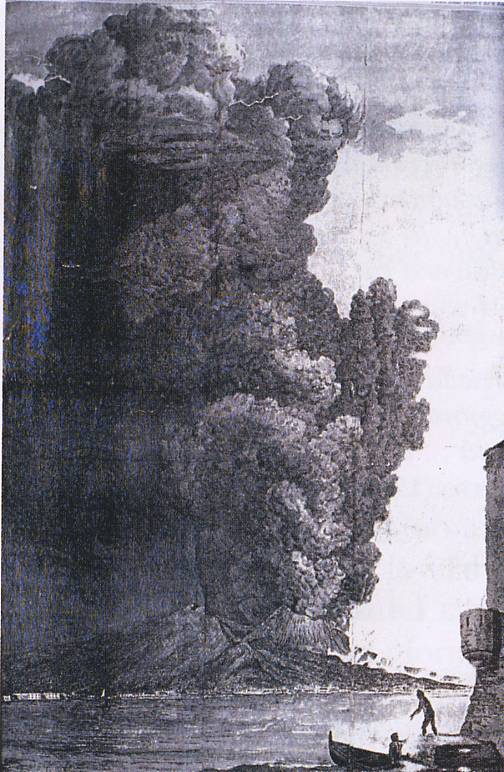
Fig.
17 –
Fase esplosiva del 18 Giugno 1794. Formazione di una nube eruttiva
collassante su Somma e Ottaviano. Da una gouache di Saverio Gatta
eseguita da Napoli (Hamilton, 1795).
«
... Si vedeva uscire dalla cima del cono una densa nuvola in forma di
globo, la di cui superficie era granulata, come appunto d’un calcolo
fiore, ed a misura che s’andava sollevando sembrava gonfiarsi e
dilatarsi ... Si scorgevano in essa alcuni corpi dotati di maggiore
gravita specifica, che ricadevano all’in giù, ne potevano seguire l’innalzamento
della nuvola; appena questa era sortita dalla bocca, pria che si potesse
dissipare ne veniva immediatamente un ’altra e così di seguito ... e
si sollevavano ad un ’altezza sempre crescente e maggiore di quella
della montagna ... sorgevano delle nubi che s’innalzavano ad un’altezza
più grande ed erano formate d’una maggiore quantità di materia ...
Le materie che le componevano erano pezzi di lave antiche, scorie
infrante e ceneri. Le più pesanti salendo ... ricadevano ... altre
rotolavano pel dorso esterno del cono; le ceneri erano trasportate dal
vento e siccome in quei giorni le piogge dirotte
sono state molto frequenti, l’acque piovane unite alle medesime acquistavano un maggiore volume e scendevano dalla montagna in forma di vasti
torrenti di fango ...».
Breislak R Winspeare (1794).
«...
In questo stesso giorno (mercoledì 18; N.d.R.) comparve un nuvolo
smisurato sparso di immense protuberanze, simile a quello che si è
osservato nelle altre eruzioni e che ... fu chiamato pino per la figura
...». Barba
(1794).
«...
Il fumo ... sembrava uscire ondeggiante, rapido, e denso da molte
nuvole, che coprivano l’apice del cono. Quanto più si allontanava
più si schiariva e si spandeva per la resistenza che trovava nell’aria
... l’altezza cui ascendeva questo fumo, misurata da Napoli, era di
gradi 30. Il suddetto fumo ricadeva di lato, tostoché la forza di
gravità superava quella di projezione ... Per lo chiaroscuro che in esso
si ravvisava, rappresentavano da una parte piccioli monti rilevati,
delle cupe e profonde valli; dall’altra figuravano un albero di pino
simile a quello, che ci descrive Plinio ...».
Scotti (1794).
Dopo
la fase esplosiva avvenuta il 18, intorno alle ore 20 dello stesso
giorno i venti spazzarono un poco l’aria ingombra di ceneri intorno al
Vesuvio lasciando intravedere la vetta. Tutti notarono con stupore che
il cratere si era di molto abbassato rispetto all’altezza originaria,
oltre ad essere più ampio ed irregolare. Alcuni autori pongono in
relazione il collasso craterico osservato con il violento terremoto
accaduto alle ore 6 ed un quarto di martedì 17 (Duca della Torre, 1794).
Non è certo, quindi, che il cono vesuviano sia esploso proprio in quel
momento del terremoto in quanto esso nei primi due giorni dell’eruzione
rimase nascosto alla vista dei cronisti.
«...
Nello spazio de’ due giorni 16 e 17, il cono del Vesuvio era stato
sempre ingombrato da una densissima pioggia di cenere; così che non si
poteva distinguere ... nella mattina del 18 vi fu un breve periodo di
tempo, in cui diminuita la cenere ... si presentò il Vesuvio abbassato
dalla sua primitiva altezza e viddesi crollata la parte superiore del
cono ...». Breislak
& Winspeare (1794).
Molti
autori (tra cui: F.M.D.C.A.T., 1794; Barba, 1794; Caneva, 1794; D’Onofrio,
1794; G.M.C., 1794) descrivono lo stato morfologico |