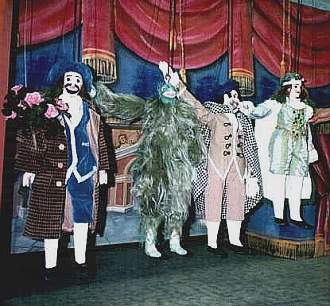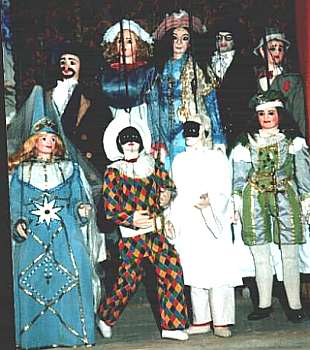|
CENNI STORICI
IL NOME - PUPI
A NAPOLI E IN SICILIA
Scarsissime sono le notizie pervenutoci da coloro che
scrivevano nel secolo passato, è ha quel poco di quello prima e all’altro
scritto in questo secolo, aggiungo le cose mie vissute in prima persona
per ricostruire una parte di storia della tradizione napoletana.
Incomincio con quello che ho potuto captare con le ricerche fatte;
coloro che hanno scritto non hanno detto tutti la stessa cosa è le
notizie non collimano e io qui riporto tale è quale come ce l'hanno
tramandate: c’è chi dice che si chiami opera dei pupi per le storie
guerresche rappresentate, questa è la prima versione che secondo me non
è giusta, da anni ho sempre saputo che il pupo è una marionetta “armata”
è va detto teatro di marionette ho delle marionette, “lo ricordo bene
per averlo scritto per la prima volta con la tinta e il pennello ha
lettere cubitali sopra l’entrata del teatro di via Antonio Luisi a
Torre del Greco nel 1939” , diciamo una buona volta che tre sono i
nomi dei pupazzi in Italia, “MARIONETTA” ch'è quella completa di
corpo gambe e braccia, il nome li fu dato a Venezia (4).
L’altra senza corpo senza gambe si chiama “BURATTINO” (5) e nel
napoletano “Guarattella” mentre “FANTOCCIO” è il nome generico,
queste cose furono pubblicato per la prima volta nel 1875 sulla Nazione
di Firenze da YORICK (6). Un altro quesito enigmatico è quello di
capire dove sono nati i primi fantocci?…Anche per questo troviamo
versioni diverse: uno ci dice in Egitto, l’altra in Cina, altre ancora
in Grecia. Quest’ultima può essere la più attendibile per le
testimonianza pervenuteci da Semafonte, da Platone e da Aristotele,
uomini della Magna Grecia.
Nel medio evo i pupazzi operavano nelle chiese è rappresentare
spettacoli religiosi illustrando scene della storia Santa. (7) Nel corso
dei secoli li chiamavano fantochini (nome che si dice solvente di
Generale). Io ricordo che tanti anni fa i soldati dell’Esercito
Italiano li chiamavano “fantocci”. …
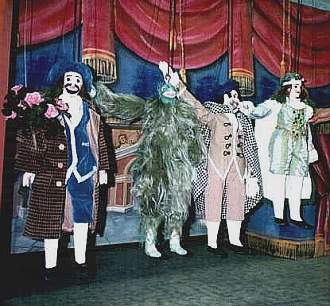
Mostro in scena
La presenza di questi fantocci nell’antica Roma ci viene conferma da
“Tito Petronio Albitro” e “Marco Aurelio” (8). Gli antichi
romani li chiamavano “Pupae imculai animatae sigillae e homunculi”
da questo pare che sia stato estirpato il nome latino che conosciamo ed
è un vezzeggiativo che si da ai bambini romani usato ancora oggi; per
questa si può supporre il nome pupo nasce a Roma. Sappiamo che opera
per eccellenza è il concorrere di tante arti insieme e lo si può
attribuire a tutte le cose artistiche, i pupi, fatti da un artista
scultore del legno è un opera propria, le due cose messe insieme si
ricava l'opera dei pupi.
Cercando, cercando, troviamo che le marionette armate furono introdotto
a Napoli per la prima volta dai Titores Castiglioni venuti al seguito
del vice Re spagnolo nel 1646. Fecero uno spettacolo in suo onore il “DON
CHISSIOTTE” del Cervaters autore spagnolo (9). Dopo questo avvenimento
troviamo tutto buio per circa due secoli, la storia a Napoli si riprende
nella prima metà del 1800, con i teatri che fecero da caposcuola: LA
STELLA CERERE ubicata nei pressi di piazza Mercato, il “MASANIELLO”
in via della Marinella, il “SILFIDE” , il “SEBATO” dove furono
messi sulla scena per la prima volta avventure di sangue e di Briganti,
il teatro della mamma di Antonio Petito “DONNA PEPPA” all'epoca
Giuseppina Del Rio, il suo teatro ci viene segnalato in più zone della
città, alla Marina delle Limoncelle in zona porto, al largo del
Castello, a Porta Capuana, nelle vicinanze di piazza Mercato, nei
Quartieri Spagnoli, in via Mezzocannone; per tutte questi suoi
spostamenti venne definito un baraccone mobile con una tendopoli come
quelle dei Circensi.
Un’altro teatro che ha fatto storia e va ricordato nasce negli ultimi
anni de lo stesso secolo in zona porto con il nome “ERCOLE” dopo poi
quando il piccone distrusse il glorioso “SAN CARLINO” di piazza
Castello nel 1894 il proprietario dell'Ercole Salvatore Buonandi si
appropriò di quel nome è ribattezzo il suo teatro di Foria ch'era
accanto porta San Gennaro era lui l'artefice dopo di lui continuarono i
figli e poi cedettero tutto alla sorella Angela moglie di Don Gennaro
‘O Scassacarozza gestore del Cinema teatro PARTENOPE ch'era ha pochi
passi da l'opera dei pupi in piazza Cavour, don Gennaro con tutta la sua
famiglia abitavano al piano superiore della Partenope e in soffitta
avevano il deposito dei pupi e altro materiale teatrale, negli anni
cinquanta crollò una parte dell’Ospedale Inguaribile ch'era alle
spalle del cinema sotterro tutto il materiale pupi compresi, per tutto
il tempo della lunga causa civile impugnata da don Gennaro contro
l'amministrazione dell'Ospetale, dopo anni quanto mossero le macerie il
materiale sotterrato non era più ricuperabile.
Il San Carlino di Foria era a regola teatrale con posti di platea due
ordini di palchi e il loggione per la piccionaia. L’ultimo a gestirlo
prima della chiusura totale fu l’amico GIUSEPPE FERRIERO conosciuto
come “Peppe ‘O Fricchione”: la chiusura di questo teatro è stata
veramente un peccato era l'unico teatro dei pupi che poteva restare come
testimone di una tradizione che non c'è più, poteva essere attrezzato
come museo del settore, avrebbe fatto da monitor per il turismo, in quel
teatro si poteva creare una scuola di avviamento all’arte dei pupi per
i giovani come hanno fatto a Palermo e a Trieste (10).
Un’ altro teatro che durò più di vent'anni nello stesso locale fu
quello dove ho imparato l’arte a Torre del Greco.
Dai primi teatri detto vennero fuori i giovani per l'arte è le grandi
famiglie per la diffusione in tutto il territorio Campano, Calabria,
Puglia e Basilicata, gli uomini si barbicarono nelle province
"detto" facendo teatro e i figli hanno continuato la
tradizione per tutta la metà del secolo. Le famiglie sono state
numerose non tutti i figli appresero l’arte del padre qualcuno
s'inserì in altri settori.
Le famiglie che hanno fatto la storia dalla metà del 1800 in poi. Sono
i Di Giovanni, i Corelli, i Perna, i Buonandi più numerosi sei i
capostipiti dopo i figli per tutto la metà del 1900 e adesso troviamo
gli eredi non solo nel meridione ma anche in altre regione d’Italia:
di queste famiglie ne ho già parlato più in dettagliato in un’altra
mia pubblicazione (11) questo è una continuazione di quando già detto:
un nipote di quel Luigi Buonandi "quello che fece lavare il camice
di Pulcinella" un Luigi anche lui era un commediante, si trasferivo
da un paese all'altro si raffermò in Toscana, troviamo l'erede a
Firenze la figlia Maria: nella città di Benevento ci sono altri due
attori commedianti Mario e Carmine nipoti di Domenico, un altra Maria
figlia di Giovanni lasciò le scene per farsi una famiglia a Taranto,
questi tre li ho conosciuti per la prima volta nel 1944 quando lavoravo
con Arturo Vedrano, con Mario e Carmine ci siamo rivisti altre volte a
Napoli nella galleria Umberto 1° dove una volta era il ritrovo dei
teatranti, "nel 1946 sotto la galleria mi scritturarono per una
recita staccata ad Averza, arrivato sul posto la sera del debutto nello
stesso teatro c’erano i fratelli Carmine e Mario con la compagnia a
quasi tutti di famiglia per la prosa, fecero CICCI ‘O PEZAIOLE DO
CARMENE io era per il varietà che facemmo dopo la prosa".
Non sono un parente di questa grande famiglia so tutto perché amico di
famiglia da sempre, ne parlo per la passione all’arte teatrale; per
ultimo non posso ignorare chi ancora sta sulla breccia con amore e
tenacia nello spettacolo, e pare che sia l’ultima della famiglia che
ha fatto la storia dell’opera dei pupi nel napoletano dico della
signora Alba Buonandi maestra di danza a Torre del Greco esercita da
anni la professione con grande capacità; la signora Alba ce la nel
sangue l’arte, la ereditato dal nonno e dal bisnonno Pasquale anche
lui.
Era una vecchia tradizione meridionale battezzare i figli primo figlio
col nome del nonno, col passare degli anni troviamo più persone della
stessa famiglia con il solito nome, esempio “Rossi figlio di Rossi
nipote di Rossi”, così hanno fatto gli antenati della maestra Alba.
Con le notizie raccolte da più fonte mi consentano ricostruire come e
quando questi si allontanarono dalla città capoluogo, sappiamo che il
grande sviluppo del settore e avvenuto nel XIX secolo, una decina d'anni
prima delle finiva di quel secolo si scioglie la compagnia diretta da
Francesco De Simone (maestro di tutti), gli allievi si misero in
proprio, i Buonandi a coppia tra fratelli restarono fino a quando i
figli si fecero adulti si moltiplicarono le compagnie.
|
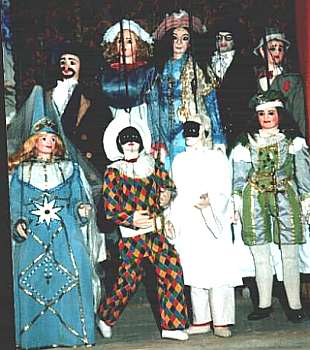
Maschere per fiabe e leggende
Ci fu chi rimase
a operare a Napoli e chi si allontanò ha cercare altre piazze, Filippo
Buonandi con i figli Carmine Vincenzo e Maria, scelsero per primo Torre
del Greco una tappa di pochi mesi si trasferirono a Castellammare di
Stabbia dove la figlia Maria si sposò con Francesco Verbale da questo
matrimonio nacque Ciro “l’erede all’arte”, un bravo maestro e
autore di testi (vedi).
Ciro ha portato avanti la tradizione fino alla metà di questo secolo.
Pasquale Buonandi con i figli Salvatore, Pasquale, Alfredo e due figlie
femmine vennero a Torre è coprirono la piazza lasciato da Filippo, i
figli di Pasquale si accasarono in questa cittadina lasciandoci gli
eredi che troviamo ancora oggi. Domenico "della stessa
famiglia" con i propri figli Giovanni e Carmine con lo spettacolo
viaggiante girano per la Calabria in Puglia è la Basilicata.
Luigi e Salvatore rimasero a lavorare nel San Carlino a Napoli. Gennaro
(anche lui un Buonandi) con i figli Alberto, Angelo e Salvatore da
Giugliano si trasferirono a Portici anche questi hanno esercitato come
gli altri già detto. Nicola Corelli anche lui dalla scuola del De
Simone, con i figli Vincenzo e Amedeo Alberto e Arturo approdarono a
Torre Annunziata, aprono teatro stanno uniti fino a quando muore il
capostipite Nicola, dopo i fratelli si divisero: Vincenzo rimase a Torre
Annunziata, Amedeo apre teatro a Castellammare di Stabbia e copre il
vuoto lasciato dal Verbale per trasferirsi a Napoli città. Arturo apre
il Teatro Corelli a Trecase che poi lo trasforma in un cinematografo. Il
quarto figlio si avvia ad un altro lavoro di lui si sono perse le
tracce. Luigi Di Giovanni (per i colleghi Luigiello ‘O Guaglione) con
quattro figli, Antonio, Vincenzo Giacomo e Saverio rimasero a lavorare
nella città capoluogo aprendo e chiudendo teatri.
Ho parlato solo delle famiglie più numerose che possono essere definiti
i pilastri portanti di questa ormai sparita tradizione popolare durata
per più di un secolo. Ci sono stati altri personaggi anch’essi bravi
ma che non hanno lasciato eredi all’arte come: Giovanni La Rocca,
Gennaro Ferrara, Mimì Finizio, Francesco Abruzzese, Vincenzo Russo,
Giuseppe Cristiano "genero di Pippe Buonandi" ed altri,
Gennaro De Simone figlio di Francesco aveva un solo figlio che non ha
accettato l’arte di suo padre, Ciro Perna "‘O Scudiero”, il
figlio Giuseppe ci ha lasciato l’erede Ciro junior con sede a
Frattamaggiore recentemente scomparso e sono rimasto l'ultimo
depositario dell'opera dei pupi napoletani.
Un altro teatro che va ricordato è il PERRELLA (12) ubicato nel
quartiere Stella nel rione Sanità dove ci andava spesso un ragazzo che
seguiva con interesse i movimenti legnosi del pupo per poi imitarli alla
perfezione, il piccolo Antonio Clementi. Cresciuto il ragazzo entra a
lavorare nel mondo dello spettacolo conquista la grande platea del
teatro prima e quella del cinema dopo a fatto tanti filmi con successo
tanto che lo giudicarono il re della risata è inutile fare giochi di
parole perché mi avete capito vi parlo del Principe De Curtis, l’attore
marionetta per eccellenza fino all’inverosimile. Al grande Totò ci
sentiamo di riconoscerlo come il portavoce indimenticabile di tutti i
marionettisti d’Italia.
L’Arte del pupante ero assai faticoso e stressante non paragonabile a
quella dell’attore di teatro e del cinema, veniva poco considerato dai
critici, per loro erano teatranti di seria B non si occupavano di loro,
solo adesso lo stanno rivalutando (d'oppe muorte mbuzarate).
In questi ultimi anni è entrato a fare parte del teatro di animazione
come tutti gli altri fantocci, prima nessuno si occupava dei fatti loro,
ragione per cui sono rimaste pochissime tracce dei pupi napoletani
mentre troviamo molto dei Siciliani, di questi si e detto tutto dal' A
ala Z, se per caso si parlava con altri nella Galleria ha l'epoca del
ritrovo dei teatranti alla domanda cosa sai fare e tu li rispondevi
quale era la vera tua professione ti sentivi rispondere “già chille
‘e l’opere ‘e pupe” è ti trattavano come uno da poco perché
non sapeva nulla del tuo lavoro, più volte il maestro a questi signori
li rispondeva “perché quello dell’opera dei pupi non è un uomo
come l'altro? Sono figlio d’arte vengo dal casotto” come se volesse
dire vengo dalla gavetta.
Un aneddoto: nel 1946, lavoravamo nel teatro del Popolo (un teatro con i
pupi) accanto al teatro Partenopeo, all'epoca Oscar DI Maio recitava li,
una sera ci venne a far visita sul palcoscenico per guardare da vicino
come si svolgeva il lavoro. Restò con noi per la prima parte dello
spettacolo, quando ci salutò disse "voi siete più artisti di noi
con gli occhi leggete la parte, con le braccia animate il pupo di un
certo peso, con i piede fate i rumori e date il tempo al combattimento,
noi recitiamo facciamo qualche gesto e basta”.
Un complimento fattoci da un attore regista e commediografo quale lui
era negli anni quaranta e cinquanta aveva la sua importanza. Il lavoro
del semplice pupante terminava con la fine dello spettacolo, quello del
direttore non finiva allo stesso modo dopo l’ultimo spettacolo serale
tornava a casa è preparava la spettacolo per la sera dopo.
Dai vecchi copioni scritti da più di un secolo tagliava le scene più
noiose che riteneva insignificanti lasciando lasciava le migliori,
avvolte da due copioni ne faceva uno con il cancellare e aggiungere
battute, dopo di questo se ne andava a letto, alla mattino dopo
cominciava la giornata nel teatro scrivendo il cartellone per la serata
esponendolo fuori dal teatro, nel deposito spogliava e vestiva i pupi,
anche questo lavoro gli portava via del tempo, finiva alle ore 14 per
andava a desinare e riposarsi, alle 17 apriva il teatro e alle ore 18
iniziavo il primo spettacolo, l'altro alle 21.
Nei giorni festivi gli spettacoli erano tre: il primo alla 16, la sala
si riempiva di ragazzi che facevano una caciara dell’anima tutto il
tempo dello spettacolo si sentiva solo il vociare dei ragazzi ne una
parola della nostra recitazione proprio come fanno oggi i giovani quando
vanno a sentire un concerto delle Star; sono un pessimista e sospetto
che i grandi cantanti nell’urlare degli spettatori pronuncino anche
parolacce e mandino accidenti come facevamo noi ai ragazzi che non s’azzittivano
nemmeno all’invito “fate silenzio per piacere” ci costringevano ha
dire qualche parolaccia: ho detto d’essere pessimista ma non sono
maligno per sospettare dei nostri divi che vanno per la maggiore e fanno
il loro lavoro con gli apparecchi elettronici a tutto volume. E’ l’epoca
dei rumori non solo per gli apparecchi sofisticati della musica e il
canto ma per quello delle macchine e motorette che ce ne tante, non so
se sono nocivi alla salute.
Cercando cercando, troviamo che i pupi a Palermo sarebbero arrivati col
napoletano Gaetano Greco nel 1826, e rappresentava storie di Pulcinella
e Culumbina. Un suo discepolo Liberto Canino due anni dopo si mette in
proprio e si contende il primato di essere stato il primo puparo
palermitano, ma viene riconosciuto solo come allievo di don Gaetano ed
è un dato di fatto.
Altri ci dicono che i pupi nell’isola sarebbero sbarcati per una
tradizione romantica legata al Risorgimento nel 1861 per opera di
Giovanni Grasso nonno dell’attore omonimo “mercante” di pellami e
fustagno per sfuggire ai doganieri borbonici ripiegò a Napoli (13) dove
imparò l’arte del puparo e dopo l’unità d’Italia se ne ritornò
a Catania. Aprì il suo primo teatro nel corso Garibaldi lo chiamò
teatro MACHIAVELLI avviò storia di “GUERIN MESCHIMO” del Barberini;
un'altra fonte ci indicherebbe come il più antico puparo Catanese “Gaetano
Crimi” con il suo teatro a Catania già nel 1837 (14): non so quale
versione sia quella giusta, a mio avviso direi la prima per la tecnica
usata dagli operatori catanesi per essere troppo uguale alla tecnica
napoletana i pupi vengono manovrati dall’alto di un ponte istallato
sul fondo scenico, fanno uscire i personaggi cristiani dal lato sinistro
dell’operatore e quelli pagani dalla destra, i pupi hanno sempre la
spada in pugno, i colori delle veste sono il rosso per Orlando e il
verde per Rinaldo, sono tutte cose uguali, precise alla tecnica
napoletana, sola il combattere e come tutte la tecnica siciliana l’asticella
di ferro sulla mano destra e non il filo come i napoletani.
A Palermo è tutto il contrario di quando ho detto; l'uscita dei
personaggi i colori delle vesti, il verde per Orlando e il rosso per
Rinaldo, la manipolazione del pupo viene fatta da dietro le quinte
l'animatore è sullo stesso piano del pupo e non dall'alto di un ponte
come i napoletani e i catanesi, alla Sicilia una cosa sola li va
riconosciuta ed è quella di non arrendersi e portare avanti la
tradizione secolare con tenace, mentre i napoletani hanno sotterrato la
tradizione lasciandoci pochissime tracce. |