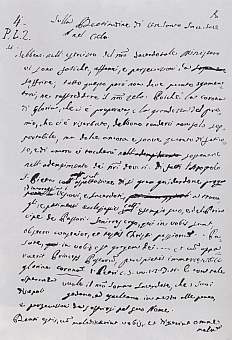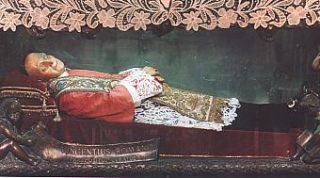|
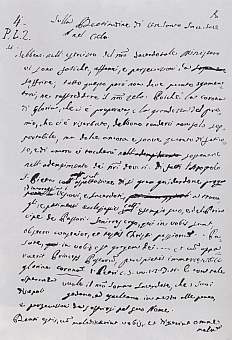
Pagina autografa di una
predica del Beato
ai sacerdoti
Il capitolo IX invece raccomanda di svolgere la lezione di catechismo in
forma dialogica e suggerisce di premiare i migliori. Ma la più antica
confraternita di Torre del Greco era quella dei Bianchi, sotto il titolo
di Santa Maria della Misericordia e San Giovanni Battista Decollato,
fondata nel 1574 con 1’unica finalità di «prestare al prossimo le
opere della misericordia spirituale e temporale». Don Ferrante Bucca d’Aragona,
che aveva fatto erigere a Torre 1’ospedale degli Incurabili nel 1586 e
una chiesa dedicata a Santa Maria del Popolo, in cui tre sacerdoti
assistevano i moribondi, dono alla compagnia una cappella contigua alla
chiesa suddetta affinché i fratelli si esercitassero nelle opere di
misericordia, specialmente verso gli infermi.
In seguito i fratelli si dedicarono all’assistenza esterna agli
infermi e si adoperarono soprattutto alla difficile opera di confortare
i condannati a morte. Ma, avvenuta una lite tra la confraternita dei
Bianchi di Torre del Greco e quella di Napoli a causa della stessa
denominazione, la confraternita di Torre si separo da quella di Napoli
di cui era promanazione diretta e si aggrego a quella di San Giovanni
Decollato de’ Fiorentini in Roma, grazie a una speciale Bolla concessa
alla compagnia dal papa Paolo V nel 1612, partecipando dei medesimi
privilegi e delle prerogative di quella. In memoria di tale aggregazione
al primo titolo di Santa Maria della Misericordia fu aggiunto 1’altro
di San Giovanni Battista Decollato.
I primi statuti dell’arciconfraternita furono in parte modificati
quando si provvide a rinnovarli, secondo le esigenze dei tempi: le nuove
Regole furono approvate prima dalla compagnia e poi dal re con decreto
del 19 febbraio 1839. La confraternità fu in auge nel secolo XVIII. Vi
appartennero i migliori sacerdoti e i laici più qualificati, non solo
di Torre del Greco ma anche di Ercolano e di Napoli. Don Ignazio
Sorrentino (1663-1737), sacerdote torrese e famoso vulcanologo, come
superiore della Congrega dei Bianchi, compilo una Prattica per
confortare i condannati a morte, pubblicata a Napoli nel 1712 e
ancora osservata nel 1839.
L’alta stima in cui la confraternita era tenuta comporto la buona
manutenzione che poteva ammirarsi nell’interno fino agli inizi di
questo secolo. Qui convenivano gli Eletti di Torre, Ercolano e Portici
per la nomina del governatore da presentarsi alla Real Camera.
Il compito primario della confraternita nel Settecento fu quello di
assistere i carcerati e i condannati a morte. Essa ave- va 1’autorizzazione
ad assisterli fino all’esecuzione della pena capitale in tutta la
provincia di Terra di Lavoro e in qualsiasi altra parte del Regno di
Napoli, come risulta dalla santa visita del cardinal Spinelli,
che volle arricchire l’arciconfraternita di altri privilegi.
Al tempo di Vincenzo Romano la confraternita, oltre al compito ordinario
di erogare delle somme in favore dei carcerati e dei condannati a morte,
assunse l’onere di pagare il riscatto dei corallini caduti nelle mani
dei barbareschi.
|
Infatti, al tempo
della scoperta del banco di Galita (1783), molti furono i pescatori di
corallo torresi catturati in schiavitù dai corsari barbareschi. Tale
attività era cessata alla morte di Vincenzo Romano e non se ne fa più
menzione nelle Regole del 1839, che fisso il numero dei fratelli a non
più di cento, di cui sessanta ecclesiastici e quaranta laici, tutti
nativi di Torre del Greco e non inferiori a ventun anni.
Ad essa potevano appartenere ecclesiastici almeno suddiaconi,
professori, impiegati e proprietari, insomma tutte persone altamente
qualificate. I fratelli venivano ammessi il 23 giugno, vigilia di san
Giovanni Battista, dopo i vespri, e il 2 novembre, commemorazione dei
defunti, dopo 1’ufficio e la messa di requie. Indossavano un camice
con cappuccio di tela bianca e fina, un cingolo bianco di lino o cotone,
un cappello bianco che con un laccio veniva attaccato al cingolo nel
fianco sinistro, e uno stemma che rappresentava nella
parte superiore santa Maria della Misericordia, nel mezzo la testa di
san Giovanni Battista decollato e al di sotto un condannato assistito da
due sacerdoti della compagnia. L’arciconfraternita e stata distrutta
nel bombardamento del settembre 1943. A Torre del Greco nel secolo XVII,
esisteva anche una confraternità francescana nella chiesa di Santa
Maria delle Grazie, come risulta da una Cronaca inedita del padre
Teofilo Testa da Nola (1631-1695), pubblicata recentemente.
La congregazione nacque per opera del francescano torrese Damiano d’Ascione
che, dopo aver costruito la chiesa della Ma- donna delle Grazie, diede
una bella cappella ai marinai e ai pescatori, che la dedicarono all’Immacolata
Concezione e vi fecero anche i loro loculi. Caduta la chiesa nell’anno
1650, ma non la cappella che divenne sacrestia, essi furono costretti a
prendere un’altra cappella per loro sede, più piccola essendo la
nuova chiesa ricostruita più piccola, e la dedicarono sempre all’Immacolata
Concezione.
Ma nel 1676 dovettero cambiar sede e trasferirsi temporaneamente in una
cappella di Santa Croce a causa di un frate indegno che li mando via, ma
poi si stabilirono definitivamente nella cappella di Santa Maria di
Costantinopoli. La confraternita aveva un cappella- no e due inservienti
a proprie spese; celebrava diverse festività durante 1’anno, fra le
quali quella dell’8 settembre (Natività di Maria), trasferita all’ultima
domenica del mese, trovandosi fuori i marinai per la pesca. Disponeva di
un Pio Monte detto « dei Marinari », fondato nel 1639 per i loro
propri vantaggi: in primo luogo pagare 1’intero riscatto di quanti
fossero fatti preda dei « barbari corsari».
Il Pio Monte era amministrato da sei persone, tre padroni di feluche e
tre pescatori. Nel 1668 i confratelli, per incrementare il capitale del
Pio Monte, decisero che ciascun aderente al sodalizio desse il quarto
del guadagno al detto Monte, offrendo pero altri sussidii (come in caso
di matrimonio delle figlie o di malattia), e perché non vi fossero
frodi, supplicarono il cardinal Innico Caracciolo di pubblicare un
editto per render noto a tutti il memoriale sopraddetto. Il cardinale 1’approvo,
comminando pena di scomunica contro quelli che avessero defraudato la
cappella del detto guadagno secondo 1’esposto. Nel 1674 il principe di
Stigliano dono la cappella di Santa Maria di Costantinopoli, di sua
proprietà al Pio Monte dei Marinai, che ebbe qui la sua sede
definitiva. Essendo sempre più elevato il numero dei componenti e più
forte il cespite d’entrata, il Pio Monte trasformo la cappella in
chiesa; essa risulto completata nel 1700, come ancora si legge sull’arco
della volta.
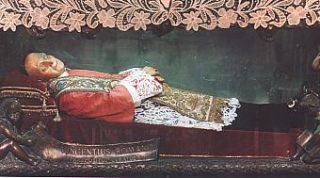
Urna del
Beato nella Basilica di S. Croce
|